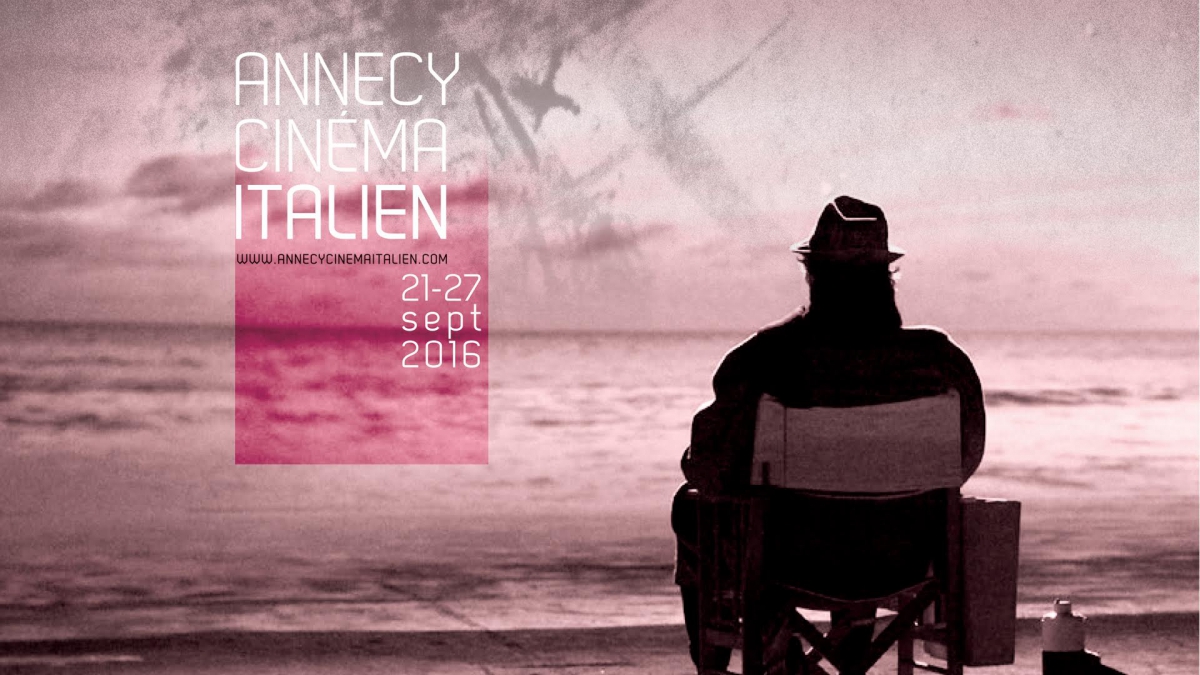Fiore

Dopo la Quinzane des Realisateurs di Cannes torna in Francia Fiore, presentato al festival di cinema italiano di Annecy. Gli autori Filippo Gravino, tra i più prolifici sceneggiatori del momento (Veloce come il vento, Alaska, Perez, Gomorra La Serie e altro), e Antonella Lattanzi, scrittrice, tra l’altro, dei romanzi “Devozione” e “Prima che tu mi tradisca”, hanno scritto la sceneggiatura insieme al regista Claudio Giovannesi seguendo un metodo rigoroso di studio del reale.
Come da consuetudine apriamo l’intervista con un pitch del film…
Filippo: Fiore è la storia della possibilità di un amore in carcere. Un luogo quindi dove l’amore non sarebbe permesso. Si racconta come passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, una ragazza conquista la possibilità di innamorarsi.
Pitch perfetto! Ho letto che il film nasce da un laboratorio fatto in carcere con dei ragazzi, ci raccontate meglio questo processo?
Filippo: Questo è il terzo film che faccio con Claudio e ormai abbiamo un nostro metodo, in cui è entrata anche Antonella. Il metodo è partire da un’idea, che in questo caso era la possibilità di innamorarsi dentro un carcere, e poi andare a verificare nella realtà se e come questa idea esiste. Quindi abbiamo organizzato un corso per i ragazzi di un carcere e per quattro mesi siamo stati nell’Istituto penale di Casal del Marmo, tre volte a settimana per tre ore, incontrando un giorno i più piccoli, un altro giorno i più grandi e poi le ragazze. E per quattro mesi abbiamo fatto soltanto questo e ci facevamo raccontare le loro storie, cercando la materia per il film. Usciti da lì avevamo molto materiale, c’erano mille film possibili, ma per seguire il metodo dovevamo tener fede all’idea di partenza. Questa è una tentazione che c’è ogni volta, perché vengono fuori un sacco di storie interessanti, ma bisogna mantenere la rotta e abbiamo selezionato solo quelle legate all’amore in carcere.
E la scelta di avere come protagonista una ragazza c’è stata fin da subito?
Antonella: Si, l’idea era proprio di fare “Il tempo delle mele” in carcere, è sempre stato quello il punto centrale, se ci può essere un amore adolescenziale da tempo delle mele in una situazione oscura e claustrofobica come il carcere. Se ci può essere un fiore in una realtà così.
Tu Antonella in che fase sei entrata nel progetto?
Antonella: Dopo il soggetto, che era stato scritto da Claudio e Filippo, mi hanno contattata, perché Claudio aveva letto il mio romanzo Devozione e aveva notato un’affinità, perché anche a me piace molto guardare il reale. Poi io avevo visto Alì ha gli occhi azzurri e mi era piaciuto davvero molto, così come anche il documentario Fratelli di Italia. Quindi per me era davvero una bella occasione, anche perché questa è la prima sceneggiatura a cui ho lavorato. Quindi è un linguaggio diverso, poi ho imparato molto da loro durante il lavoro e anche l’esperienza in carcere è stata incredibile. Quattro mesi duri, ma molto belli, un confronto con una realtà che altrimenti uno non conoscerebbe mai, anche perché si parla di più del carcere per gli adulti, che del minorile. Vedere chi sono i ragazzi che sono in carcere, che cosa fanno e come siano allo stesso tempo ragazzi e anche adulti, perché hanno avuto vite molto dure.
Filippo: Tutto quello che c’è nel film, la vita della protagonista, i suoi legami familiari e il rapporto con il padre, nasce tutto dai racconti reali dei ragazzi. Siamo stati molto fedeli alla realtà.
Dopo i quattro mesi in carcere, quali sono stati i tempi di scrittura?
Antonella: In tutto un anno e mezzo, due anni forse. La prima stesura ha preso qualche mese.
Filippo: Abbiamo finito il corso in carcere ad aprile e prima dell’estate avevamo la prima stesura, a luglio. Poi dopo ci sono state altre sei o sette stesure.
La produzione a che punto è entrata nel progetto?
Filippo: Da subito, noi siamo andati in carcere già sapendo che avevamo un produttore alle spalle. Il soggetto era già stato acquistato. Altrimenti non ci saremmo presi il rischio di un lavoro così lungo e anche difficile psicologicamente. Il produttore che ci ha spinto a cominciare era Fabrizio Mosca, che poi si è unito alla Pupkin di Rita Rognoni, che ha gestito tutta la parte finanziaria ed è stata di grande supporto.
Per WGI infatti una questione cruciale è proprio il rischio imprenditoriale che spesso pesa esclusivamente sulle spalle dello sceneggiatore, che si mette a scrivere senza nessuna garanzia produttiva.
Filippo: No questo non è possibile soprattutto per un lavoro di questo tipo. Troppo rischioso. Quattro mesi in carcere senza la certezza di avere poi un copione sostenuto produttivamente non è possibile. Devo dire che ultimamente a me capita sempre così, nel senso che io autonomamente sviluppo dei soggetti brevi che poi consegno alla produzione per iniziare l’iter di sviluppo. A seconda delle idee che ho, scrivo tra le 5 e le 30 pagine, ma non ci deve essere una mole di lavoro eccessiva finché uno non ha un contratto. Poi già da un soggetto il potenziale di un’idea è ben chiaro, un produttore quindi può spendere dei soldi già dal soggetto.
Parlando proprio in termini di narrazione, nel film ho notato uno stile particolare di sottrazione drammaturgica. Non vorrei dire documentaristico perché non significa nulla, ma c’è un pedinamento dei personaggi, un seguire che rifiuta la classica costruzione drammatica del personaggio. Come è venuto fuori questo stile?
Antonella: Questo è proprio lo stile di Claudio, stare molto attaccati ai personaggi, che è quello che dà potenza al film. Si racconta quello che si vede attraverso i personaggi, senza escamotage, senza caricare troppo sui sentimenti; quello che arriva agli spettatori è sempre il fuoco dei personaggi, in base alle varie situazioni in cui si trovano, c’è sempre un fulcro che è legato ai personaggi. Poi come diceva Filippo tutti i personaggi sono costruiti mescolando invenzione e storie reali e abbiamo cercato sempre di essere attinenti al reale.
Filippo: Questo tipo di copione secondo me è tra i più difficili da scrivere, perché è un copione che non si sente. E questo per me è il massimo della scrittura cinematografica, da sceneggiatore arrivare a disintegrare il peso della penna è una delle mie più grandi ambizioni. E soprattutto è una drammaturgia che si fonda su spazi minimi e sugli oggetti. Se io mettessi in evidenza la scansione della scaletta è un copione all’americana: c’è una drammaturgia secca, con una struttura fortissima. La bellezza è che tutto questo è disintegrato dalla potenza del personaggio e dalla capacità di drammatizzare il poco, il piccolo. I colpi di scena quindi sono legati a oggetti semplici: un lettore mp3, un bagnoschiuma, un bigliettino nascosto nel carrello per il cibo. Questa è la realtà del carcere, eravamo obbligati anche noi a utilizzare quel poco che hanno i detenuti come se fossero delle pistole o dei gioielli.
Quindi lo stile narrativo deriva dal mondo raccontato, dalla realtà del carcere che avete osservato?
Filippo: Si completamente, noi abbiamo messo in scena quello che ci hanno raccontato loro. Per esempio il legame che hanno con gli oggetti è ossessivo. Se a uno di loro gli togli il lettore mp3 per loro è come se gli togliessero la macchina, o addirittura il cibo. Così come se non hanno un accendino per la sigaretta è la fine, passano la notte insonne perché non hanno da fumare. Se gli togli la telefonata settimanale ai genitori, loro rischiano di non sentire nessuno per un mese. Questi sono colpi di scena straordinari nel racconto, ma che non hanno senso fuori da quella realtà carceraria. Tutto questo nasce dalla documentazione. Questa è proprio la cifra del cinema di Giovannesi. Ma per me tutto il cinema, anche quello più romanzato, nasce sempre dall’approfondimento e dalla conoscenza di quello che si racconta. La fantasia per me conta zero virgola uno, tutto il resto è conoscenza del mondo reale. Poi il valore e il lavoro dello sceneggiatore è decidere cosa è importante raccontare.
Vorrei approfondire questo discorso della struttura drammaturgica. Tu Antonella, venendo dalla narrativa, la consideri un’imposizione o uno strumento utile?
Antonella: Assolutamente una cosa utilissima, per me è fondamentale avere una struttura solida, poi puoi fare tutti i voli che vuoi, ma devi stare dentro una storia che sia forte. Il lettore o lo spettatore devono sapere che stanno andando da qualche parte, quindi ci vuole una struttura potente che sia la base su cui costruire la narrazione.
Quindi tu fai una scaletta anche per i romanzi?

Antonella: No non faccio una scaletta, ma ho in testa la struttura della storia che voglio raccontare e soprattutto riscrivo molte volte, finché quella struttura c’è. Il lavoro di sceneggiatura mi ha aiutato molto ad affinare questa tecnica. Ho capitato l’importanza di sottrarre, di stare sul punto, di non evadere e divagare. Perché c’è un limite di tempo di racconto, hai dei minuti a disposizione, non un’infinità di pagine e in quel poco spazio devi dire tutto quello che vuoi dire e solo quello che vuoi dire. Quindi la struttura aiuta molto a stare dentro questo spazio limitato.
Quindi diciamo che la struttura serve, almeno allo scrittore. Tu Filippo cosa ne pensi?

Filippo: Si sono d’accordo che serve, ma poi io non la voglio sentire. Al cinema quando mi accorgo della struttura, sento l’artificio e mi rompe l’incanto. Nei film che mi piacciono davvero è sempre come se io la sceneggiatura non la sentissi. Anche nei lavori di cui sono più contento è sempre come se la scrittura si nascondesse. Questo per me è il grande fascino di questa lavoro: fare qualcosa che abbia la potenza e il sostegno di una colonna di marmo, ma allo stesso tempo la consistenza di un velo di seta. Quando senti il marmo non va bene per me, da autore che va al cinema sentire il marmo non mi dà soddisfazione.
Il rischio poi è che i film diventino prevedibili…
Filippo: Si ma non solo, io detesto ogni tipo di scrittura pesante: i dialoghi roboanti, le parole che non vengono fuori dalla voce del personaggio, tutto quello che è molto scritto. Non fa per me. Senza fare esempi di autori…
Diciamo che se sono stranieri li possiamo anche fare, non so mi viene in mente Aaron Sorkin che è un po’ così.
Filippo: Si infatti Sorkin non mi piace, ma è solo un’opinione personale.
Ci sono troppe parole, mentre invece in Fiore viene fuori la potenza dell’immagine. È sicuramente lo stile di Giovannesi, ma in scrittura non sempre è facile lasciare spazio alle immagini. Come avete lavorato voi tre?
Filippo: Claudio è fondamentale non solo come regista, lui scrive molto. Le nostre riunioni poi sono molto dettagliate, prima di mettersi a scrivere una scena, la scena l’abbiamo discussa a lungo e la conosciamo a menadito. Claudio è uno sceneggiatore vero e proprio e anche di grande livello secondo me.
Per chiarire lo stile visivo fate qualche tipo di pre-visualizzazione, anche solo con riferimenti ad altri film o magari quadri?
Antonella: Si abbiamo preso e discusso vari riferimenti a film, che potevano farci da modello. Per esempio un pomeriggio ci siamo visti La rabbia giovane di Terrence Malick. Claudio ha sempre dei riferimenti precisi per le scene e questo ti aiuta molto a capire dove devi andare.
Avevate altri riferimenti visivi condivisi?
Filippo: Si tutto è stato condiviso, soprattutto perché avendo fatto l’esperienza del carcere insieme avevamo visto e sentito cose che ci hanno unito, che hanno creato un immaginario comune tra di noi. Poi il nostro contributo forse più importante è stato l’organizzazione del materiale. Nel senso che dopo quattro mesi in riformatorio, avevamo un materiale enorme, una cosa come quattromila scene possibili, da cui bisogna arrivare a sessanta scene che stanno nella sceneggiatura. Quindi dopo la documentazione avevamo la testa strapiena di cose. Il primo lavoro importante è l’organizzazione del materiale, capire cosa serve e cosa no e organizzare quello che si tiene in una relazione di causa e conseguenza, quindi già in una specie di ipotesi di scaletta.
Mi spieghi proprio praticamente come funziona?
Filippo: è un lavoro su cui ormai siamo un po’ rodati, quindi Claudio già si aspetta da me questo tipo di organizzazione. Già durante la documentazione io guardo le cose in questa maniera particolare e quindi quando finiamo di solito ho già un’idea dell’inizio e della fine del film.
Ma come fate prendete appunti, fate schede…?
Filippo: Allora io no e mi prendevano in giro perché invece sia Antonella che Claudio prendevano un sacco di appunti. Io ho questa teoria che quando faccio un sopralluogo, quello che mi resta in testa, che mi rimane, è quello che poi ha dignità di restare. Poi magari i dettagli che loro si ricordavano io non li ricordavo, ma le sette cose fondamentali del film ce le avevo in testa. Poi è anche perché io mi annoio moltissimo a prendere appunti.
Antonella: è un metodo diverso, tu non hai bisogno degli appunti, perché ti rendi conto subito delle cose importanti. Mentre io ho bisogno di rileggere e così mi rendo conto di quello che è importante.
Dopo la documentazione e l’organizzazione del materiale e i brainstorming come è proceduta la scrittura?
Filippo: Ci siamo divisi le scene in tre e poi ognuno scriveva e ci si leggeva a vicenda, facendo ulteriori modifiche. Poi nell’ultima fase di scrittura di solito Claudio ripassa tutto il copione dall’inizio alla fine e se lo studia, per due settimane. Dopo questa rilettura si fanno gli ultimi cambiamenti, a volte li fa Claudio direttamente a volte li faccio io. Per esempio abbiamo aggiunto in questa ultima fase delle scene con il padre. E quando ci sono scene più spinose, dal punto di vista della drammaturgia e dell’inventiva, quelle Claudio le lascia agli sceneggiatori.
Proprio nel rapporto della protagonista con il padre trovo che si veda molto bene questo stile di scrittura per sottrazione, perché ci si aspetterebbe una scena madre di esplosione di conflitto, mentre il racconto è molto trattenuto e fatto di piccole cose.
Filippo: Si il fatto è che nella vita di questa ragazza il padre è una figura inesistente, perché è stato in galera per la maggior parte della vita della figlia. Quindi il loro è un rapporto che si costruisce nel poco spazio mostrato nel film: i colloqui familiari e il permesso di uscita. Poi per me la “scena madre” c’è, certo nello stile del film, quindi è un po’ suggerita ed è il momento in cui padre e figlia litigano nel bar e lei accenna il gesto di dargli una bottigliata in testa, che è un gesto violentissimo. Per un personaggio come la ragazza, che ha vissuto una mitizzazione del padre, fare quel gesto è una violenza sordida. Per me è una scena madre, solo che nello stile del film è raccontata in levare, come se fosse un gesto secondario, lo stesso Valerio Mastandrea, che interpreta il padre, prende il braccio della figlia come a voler nascondere quel gesto al pubblico, come a dire “Ma che vuoi fare?”
Si, in effetti la particolarità è che uno si aspetterebbe un conflitto più manifesto tra padre e figlia, con urla, liti che invece alla fine non c’è.
Filippo: Si è anche un aspetto della personalità della protagonista, che non è una che si mette a gridare e far scenate, non ha odio per il padre. È una ragazza che sta elemosinando amore e affetto, ma ha anche un certo orgoglio che fa si che, dopo aver chiesto e non aver ricevuto, decida di andare via.
Antonella: Poi c’è questo meccanismo ad orologeria che il colloquio in carcere ha un tempo limitato, quindi ci si vede e ci si parla per pochissimo tempo. Questo fa si che uno in quel tempo deve ottenere quello che vuole e non può perdere tempo mettendosi a litigare o discutere. Quello che vogliono i ragazzi è uscire da là, anche solo per poche ore. È una questione di sopravvivenza. Questi ragazzi detenuti in realtà sono in parte bambini, ancora di più dei loro coetanei fuori, ma costretti ad imparare il meccanismo adulto della strategia dei rapporti.
Anche il modo in cui è raccontata questa storia d’amore è particolare, c’è un approccio delicato ed è tutto dal punto di vista della ragazza, non di lui. Come mai?
Filippo: Diciamo che non c’è una drammaturgia del sentimento, il loro amore esiste ed è ostacolato solo dal carcere, quindi si racconta l’ostacolo, più che lo sviluppo del sentimento.
Antonella: La scelta di raccontare il punto di vista di lei c’è stata fin dall’inizio, anche per aumentare la sensazione di claustrofobia del carcere. Si vede tutto il mondo dal punto di vista unico della protagonista e quello che sta fuori non lo puoi vedere, esattamente come nella vita di un detenuto: puoi vedere entro certi limiti, quello che ti è concesso dalle guardie, dalle sbarre, i colloqui sono limitati nel tempo, così come i permessi di uscita. Questo tipo di drammaturgia è proprio legata al tema della claustrofobia del carcere. Poi l’attrice è stata molto brava a esprimere tanto anche solo con gli sguardi. Stare su di lei significa stare su tutta la storia, perché è lei lo specchio di quello che succede. Vedere il ragazzo da solo nella sua stanza non ci avrebbe dato nulla in più della storia.
Come è stato il rapporto con la produzione rispetto alla scrittura?
Filippo: Direi ottimo, ci siamo trovati molto bene, non ci hanno mai fatto richieste particolari di tagli o modifiche. Sul piano creativo la persona che ci ha lavorato di più è stata Fabrizio Mosca, che potremmo dire che è quasi uno sceneggiatore o almeno un produttore molto attento alla sceneggiatura e ci è stato anche di aiuto in certi casi.
In rapporto alla scelta del cast ci sono state riscritture, soprattutto in relazione alla protagonista?
Filippo: No, anche perché la protagonista è stata trovata a pochi giorni dalle riprese. Claudio ha fatto centinaia di provini ed è stato un processo molto lungo e sofferto, alla fine magicamente è stata trovata Daphne Scoccia, che ha anche avuto in passato un’esperienza di vita simile al personaggio. Per il suo personaggio ci siamo ispirati proprio a una ragazza che avevamo conosciuto, che ci sarebbe piaciuto anche coinvolgere, ma doveva finire di scontare la pena. Quasi tutti i ragazzi che si vedono nel film hanno avuto questo tipo di esperienze, alcuni sono in quella fase di cosiddetta “messa alla prova”, cioè quando iniziano a fare un reinserimento professionale, sempre sotto il controllo degli assistenti sociali, ma devono aver finito di scontare la pena.
Ma quindi anche se ci sono stati attori non professionisti, mi sembra di capire che il copione sia stato rispettato e ci sia stato poco spazio di improvvisazione, è così?
Filippo: Si assolutamente il film rispetta quasi alla lettera il copione e anche nei pochi momenti di improvvisazione i loro dialoghi suonavano proprio come i nostri, anche perché i nostri derivavano proprio dalla realtà di ragazzi come loro. Quindi era tutto molto omogeneo.
Questo contraddice un po’ la vulgata secondo cui questo cinema documentaristico sarebbe un po’ improvvisato e poco scritto.
Antonella: Assolutamente, anzi a me non piace neanche il termine documentaristico, lo definirei piuttosto un cinema di studio del reale.
Filippo: Poi non dimentichiamo che i fratelli Dardenne sono degli ottimi sceneggiatori, i loro film più riusciti hanno dei copioni perfetti. Ecco lo stile di Claudio si avvicina al loro cinema, direi che i Dardenne sono il riferimento più vicino. È un cinema molto scritto, ma che si nutre dello studio del reale.
Anche il tono del film è molto particolare, perché rifugge il grande dramma ed è molto delicato nel racconto.
Antonella: Si l’idea era proprio quella del Tempo delle mele, cioè di avere una leggerezza che potesse contrastare l’ambiente duro e violento in cui si svolgeva la storia.
Ecco in relazione al tema della violenza avete lavorato in un modo insolito rispetto all’immaginario di genere carcerario. Come mai?
Filippo: Innanzitutto è perché il film si svolge in un reparto femminile, dove c’è un altro tipo di violenza: rispetto a quella fisica dei maschi, c’è una violenza più sottile e psicologica, spesso ancora più terribile di quella fisica, ma meno esplicita. Nelle carceri minorili le ragazze sono pochissime, mentre scrivevamo in tutta Italia c’erano circa una decina di femmine detenute. Questo fatto di essere poche porta le ragazze ad unirsi fra di loro: piuttosto che litigare, cercano di trovare un minimo di casa anche là dentro. Nonostante i conflitti e le tensioni, alla fine si trova una civile convivenza. Ed è quello che abbiamo cercato di raccontare nel film con il rapporto tra la protagonista e la ragazza lesbica, che sta per passare al carcere vero, che per questi ragazzi è una cosa terribile, perché passano da una situazione sì di detenzione, ma comunque protetta e gentile, ad una situazione molto più difficile e dura, dove sono anche le ultime arrivate. E la protagonista Dafne, passa la notte abbracciata alla compagna per darle conforto. E non è una cosa che ci siamo inventati, sono situazioni reali.
Antonella per te come è stata questa esperienza di scrittura paragonata alla narrativa? Già il fatto di scrivere con altri è per te una novità?
Antonella: Per me è stato ed è molto bello scrivere sceneggiature. Prima di tutto perché non si seguono i propri gusti, ma si seguono le direttive di un regista. Questo per me è stato stimolante, perché ti porta a sperimentare cose che magari non avresti scritto. Poi la condivisione è anche una cosa bella. Quando uno scrive un romanzo è da solo, ci sono le cose belle, ma anche quelle brutte, le angosce e le responsabilità. Mentre lavorare con gli altri ti da la possibilità di imparare, io ho imparato molto da loro sulla scrittura in generale e penso che sia qualcosa che si riverbera anche sui miei romanzi successivi. Parlare e confrontarsi con qualcuno è molto utile, si arriva prima a capire quello che si ha in testa, mentre scrivendo narrativa uno magari sta anni da solo al computer litigando con se stesso. Poi a me piace molto scrivere cose diverse, sperimentare vari tipi di scrittura, così queste scritture comunicano fra di loro e si passano qualcosa, quindi c’è un arricchimento. Inoltre ragionare per immagini è una cosa che mi piace già nella narrativa, e nella sceneggiatura non solo bisogna forzatamente pensare per immagini, ma andare per sottrazione, perché c’è un tempo limitato e questo per me è stato davvero utile e stimolante.
Quindi hai altri progetti di sceneggiature?
Antonella: Si ci sono varie cose, non voglio dire troppo… Ma sono cose diverse da Fiore, una completamente diversa, è una commedia… Poi c’è un progetto seriale. Comunque collaboro sempre con altri autori.
E tu Filippo cosa ci puoi dire dei tuoi progetti futuri?
Filippo: Sto facendo una serie da un’idea mia, sto scrivendo il soggetto, ma non posso dire nulla di più. Poi stiamo iniziando a ragionare insieme a Claudio Cupellini sul suo prossimo film. Poi c’è la seconda stagione della serie “Tutto può succedere” e alcuni progetti di serie seminati in giro che vedremo se matureranno.